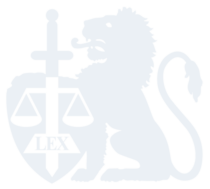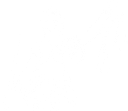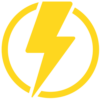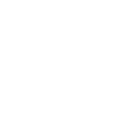Alessia Pifferi, il grave deficit cognitivo e la perizia in primo grado
Pubblicato da ISF Magazine in Psicologia e Neuroscienze · Lunedì 10 Feb 2025 · 8:15
Tags: alessia, pifferi, deficit, cognitivo, perizia
Tags: alessia, pifferi, deficit, cognitivo, perizia

Autore: prof. Massimo BLANCO
Istituto di Scienze Forensi
Alessia Pifferi, la donna condannata in primo grado all’ergastolo per aver abbandonato la propria figlia, Diana, di appena di 18 mesi, per sei lunghi giorni, sarà sottoposta ad una nuova perizia psichiatrica per un grave deficit cognitivo.
Ma cosa significa “deficit cognitivo”? Le funzioni cognitive sono tutte quelle abilità mentali che ci servono per svolgere qualsiasi attività, dalle più semplici alle più complesse. Tra le funzioni cognitive abbiamo la memoria, l’attenzione, l’apprendimento, il linguaggio, il ragionamento, l’orientamento, il pensiero astratto, il problem solving e la percezione. Specifichiamo cosa sono queste ultime due funzioni: il problem solving è un processo cognitivo che ci consente di prendere coscienza di un problema, analizzarlo, mettere in atto delle strategie per risolverlo e saper valutare i risultati, mentre la percezione è un processo cognitivo assai complesso che ci consente di elaborare, ovvero identificare, ordinare e classificare gli stimoli che riceviamo dai nostri sensi e trasformarli in forme e concetti dotati di significato.
I deficit cognitivi possono presentarsi nel corso dell’infanzia a causa di sindromi genetiche, patologie, traumi fisici o psicologici, ma anche di ambienti di crescita assai disfunzionali. In questo caso, cioè quando il disturbo insorge per via della compromissione di funzioni cerebrali in via di maturazione, siamo in presenza di una disabilità intellettiva, un tempo chiamata ritardo mentale. Invece, se i deficit si manifestano successivamente alla normale fase di sviluppo neurologico di un individuo, cioè nella fase adulta, abbiamo un disturbo neurocognitivo, un tempo chiamato demenza. Il disturbo neurocognitivo può essere determinato da un trauma cranico e da qualsiasi altra patologia che interessa il cervello, come la malattia di Alzheimer, le demenze vascolari o frontotemporali e le demenze indotte da sostanze.
Sia nel caso della disabilità intellettiva, che del disturbo neurocognitivo, si hanno delle limitazioni in quello che si chiama funzionamento adattivo, che riguarda le abilità sociali e comunicative, l’autocontrollo e l’autonomia nella vita di tutti i giorni. Si hanno, quindi, difficoltà a svolgere adeguatamente i compiti della vita, a comprendere i contesti e le situazioni e, di conseguenza, ad agire e comportarsi nel modo più opportuno.
Un deficit cognitivo può incidere sulla capacità di intendere e di volere?
Partiamo prima dal significato di capacità di intendere e di volere. La capacità di intendere è la capacità di un soggetto di rendersi conto della realtà, di percepire il significato del proprio comportamento, di avere coscienza delle proprie azioni, di comprendere se queste sono lecite o illecite, anche in funzione del contesto in cui si trova. La capacità di volere, invece, è la capacità di autodeterminarsi, di esercitare in modo autonomo le proprie scelte e di saper controllare i propri impulsi e le proprie reazioni. Per la legge, se manca anche una soltanto delle due capacità, si ha un’infermità mentale e, quindi, la persona viene giudicata o non imputabile o parzialmente imputabile, a seconda della gravità della patologia riscontrata o, meglio, della gravità dei sintomi di questa patologia al momento del delitto o nel lasso di tempo in cui si è consumato il delitto.
Un deficit cognitivo, come riportato in precedenza, può interessare una o più abilità mentali che ci servono per funzionare in modo adeguato nella vita di tutti i giorni, anche quando si presentano delle situazioni in cui è necessario effettuare un’analisi, un ragionamento e, quindi, quando dobbiamo porre in essere le strategie più idonee affinché le nostre azioni ci portino un vantaggio o abbiano una qualche utilità, restando comunque nel recinto dei valori morali, delle responsabilità che abbiamo e, ovviamente, della legge. Quindi, per determinati tipi di reato, un grave deficit cognitivo è “potenzialmente” idoneo ad incidere sulla capacità di intendere e di volere.
La valutazione psicopatologica forense del deficit cogntivo
Per valutare la capacità di intendere e di volere di un soggetto affetto da un deficit cognitivo, come avviene per le valutazioni di tutte le psicopatologie croniche o transitorie che devono essere accertate ai fini giudiziari, è d’obbligo effettuare un’indagine approfondita. Prima di tutto, è necessario accertare quali funzioni cognitive sono deficitarie e stabilire la gravità dei sintomi del deficit, in modo da avere un primo elemento di indagine utile ai fini della perizia. Le attività che vengono svolte sono i colloqui e l’osservazione del soggetto, la somministrazione di test psicologici, in alcuni casi esami strumentali, come l’elettroencefalogramma, la risonanza magnetica ecc. Nel caso in cui il soggetto era già in cura presso un presidio di salute mentale prima di commettere il reato, si procede altresì con la disamina dei documenti sanitari disponibili (relazioni psichiatriche e psicologiche, cartelle cliniche, test somministrati, esami strumentali ecc.) e con dei colloqui con gli specialisti curanti. Tuttavia, nel caso dei deficit cognitivi, l’osservazione, i test, gli esami strumentali e qualsiasi altro mezzo diagnostico non sono sufficienti ai fini dell’accertamento psicopatologico-forense. Infatti, in precedenza si è detto che un deficit cognitivo produce delle limitazioni del funzionamento di una persona. Limitazioni che riguardano la difficoltà a svolgere adeguatamente i compiti della vita, a comprendere i contesti e le situazioni e ad agire e comportarsi adeguatamente per raggiungere i propri fini. Quindi, nella valutazione complessiva del deficit cognitivo di un individuo adulto, assume particolare valore il funzionamento nella vita di tutti i giorni, cioè il grado di autonomia del soggetto. Infatti, un disabile intellettivo, da adulto, attraverso le esperienze di vita, nonostante il deficit cognitivo, potrebbe aver sviluppato un buon funzionamento adattivo. In altre parole, nonostante il deficit di partenza, il soggetto potrebbe essere in grado di condurre una vita sufficientemente autonoma, in quanto ha sviluppato delle capacità adeguate che compensano il deficit o i deficit di cui è portatore.
In seguito, bisogna verificare se il deficit cognitivo accertato è compatibile con il tipo di delitto commesso, ovvero è necessario stabilire quello che si chiama “nesso eziologico” tra sintomi e reato, cioè se l’azione delittuosa è direttamente collegata ai sintomi del disturbo. Alla fine, si deve procedere con l’analisi della criminodinamica, cioè delle modalità e dei tempi con cui è stato commesso il delitto, al fine di comprendere ancor meglio se i sintomi del deficit cognitivo sono stati la causa diretta dell’azione criminosa.
Parallelamente alle attività di cui sopra, si procede con un’indagine sul contesto sociale e familiare, nello specifico sul supporto che l’autore del reato ha ricevuto o non ricevuto da quelle persone che non potevano non conoscere o sospettare le sue condizioni mentali e che, quindi, avrebbero dovuto occuparsene per ragioni non solo morali, ma anche legali. Oltre ai parenti più stretti, tra questi soggetti rientrano le istituzioni, ovvero i presidi sociosanitari quando questi erano informati di una situazione di grave disagio e vulnerabilità o che ne avevano il sospetto.
La perizia sulla Pifferi in primo grado
Per quanto riguarda Alessia Pifferi, il suo difensore, l’avvocato Alessia Pontenani, ha dichiarato di aver reperito dei certificati medici e altri documenti che proverebbero che il deficit cognitivo della donna, cioè la sua disabilità intellettiva, era noto fin dalla sua infanzia, portando in appello questo ulteriore elemento di prova. Tuttavia, in primo grado, il perito nominato dal Tribunale, professor Elvezio Pirfo, non ha escluso categoricamente che la Pifferi sia affetta da una disabilità intellettiva e, quindi, da un deficit cognitivo, ma ha valutato il funzionamento della donna nella vita di tutti i giorni che, secondo il perito, non escludono, né diminuiscono, la capacità di intendere e di volere rispetto all’abbandono della figlia di 18 mesi per sei lunghi giorni. Il professor Pirfo ha poi contestato il test WAIS (test di intelligenza) somministrato alla Pifferi in carcere, non perché il test in questione non costituisca, nella pratica psicoforense, uno degli elementi probatori utili ai fini diagnostico-forensi di un soggetto affetto da deficit cognitivo, ma perché i risultati del test, prodotti, poi, in giudizio dal consulente di parte, prof. Marco Garbarini, erano carenti di informazioni circa le modalità di somministrazione. Inoltre, sempre le psicologhe del carcere, oltre alla somministrazione di ulteriori test oltre il WAIS, hanno svolto sulla Pifferi una serie di attività che non erano di loro competenza, in quanto avrebbero dovuto limitarsi al solo sostegno psicologico, al fine di evitare, ad esempio, atti anticonservativi come il suicidio, e hanno verosimilmente “inquinato” la fonte di prova più importante, cioè la mente dell’imputata, probabilmente suggestionandola. Infatti, il perito del Tribunale, professor Pirfo, nonostante abbia riferito di non poter affermare che la Pifferi sia stata suggestionata, ha dichiarato che la donna, durante i colloqui peritali, nel rispondere e raccontarsi ha utilizzato un vocabolario ricco di termini psicologici tipici di un soggetto che ha già svolto un percorso psicoterapeutico e che ha la capacità di apprendere, comprendere, relazionarsi, parlare, ricordare, raccontare, descrivere i propri stati emotivi ecc. Pertanto, il perito, in base agli esami effettuati (colloqui, osservazione, test ecc.) e ai dati emersi sul modo di funzionare della Pifferi prima e dopo il reato, ha concluso, correttamente, che la donna non presenta alcun deficit cognitivo tale da determinare un anomalo funzionamento adattivo in relazione al delitto per il quale, poi, è stata condannata in primo grado.
Riproduzione riservata